Stefano Drei
Con Dino Campana al Liceo Torricelli (Scarica in formato Pdf)
(Pubblicato, in Studi e ricerche del Liceo Torricelli, Faenza, 2006, pp. 135-150. Poi modificato ed integrato in alcuni punti.)
Quando Dino Campana entra per la prima volta nell'«antico palazzo rosso»1 del Liceo Torricelli non ha ancora compiuto tredici anni. Prima di lui un altro membro della sua famiglia ha frequentato quelle aule: lo zio paterno Francesco, magistrato a Firenze, vi ha seguito tutto il triennio liceale diplomandosi nel 1876. Ora siamo nell'estate del 1898; Dino, nato nell'agosto del 1885, è in anticipo di un anno sul normale corso di studi. Ha conseguito presumibilmente nel 18962 la licenza elementare; poi, troppo piccolo per lasciare la sua Marradi, ha concentrato privatamente in un anno le prime due classi ginnasiali sotto la guida del padre Giovanni e dello zio Torquato, entrambi maestri. Così, nel 1897 si è iscritto direttamente alla terza ginnasiale presso l'Istituto Salesiano di Faenza: compiuto l'anno si presenta al Torricelli per convalidare nel Ginnasio Statale, anzi «Regio» il completamento del triennio inferiore e l'ammissione alla quarta.
I candidati sono 14: undici provengono dall'Istituto Salesiano, tre «da scuola paterna». Nove, fra cui Dino, saranno promossi in prima sessione, due ad ottobre, tre respinti. La commissione che l'8 luglio 1898 firma il registro è composta dal preside Flaminio Del Seppia, dai professori Leandro Casali (lettere al ginnasio inferiore), Luigi Mazzotti (lettere al ginnasio superiore), Cristiano Rodighiero (matematica) ed Enrico Toschi (francese). Torneremo in seguito su qualcuno di questi nomi.
Ecco i voti di Campana:
|
scritto |
orale |
|
|
Italiano |
6 |
7 |
|
Versione dal latino |
8 |
7 |
|
Versione in latino |
7 |
|
|
Francese |
6 |
8 |
|
Geografia |
6 |
|
|
Aritmetica |
8 |
Sono voti discreti, non di più. In particolare i voti di francese non confermano la nota attitudine di Dino per le lingue straniere. Un otto all'orale il professor Toschi, croce del preside per la sua eccessiva indulgenza, non lo nega a nessuno; allo scritto poi il sei è ben al di sotto della media del gruppo che registra un otto, tre nove e ben sette dieci.
Che l'esame serva solo al conseguimento del titolo è confermato dal fatto che nessuno dei nove promossi appare fra gli iscritti al Torricelli l'anno successivo. Dino ed i suoi compagni di scuola proseguono in collegio il loro ginnasio. Sugli anni di Dino presso i salesiani, abbiamo la testimonianza resa tanti anni più tardi da Michele Campana, suo coetaneo e lontano parente3: «All'età di 12 anni, nell'ottobre del 1897, fummo tutti e due inviati a studiare nel Collegio dei Salesiani a Faenza. Eravamo nati nello stesso anno 1885: io l'8 gennaio, lui il 20 agosto. Frequentammo per tre anni le stesse classi, dalla terza ginnasiale alla licenza». Ma i registri dei salesiani e del Torricelli concordi smentiscono. Michele e Dino saranno certamente stati compagni di giochi nel «vasto cortile» dei salesiani, ma non sono mai stati compagni di classe. Dino, in anticipo di un anno, è partito iscrivendosi nel 1897 alla terza ginnasio, Michele alla seconda. Quindi Michele rimane ai salesiani un anno in più e compie ad un anno di distanza le tappe dell'amico: esame di ammissione alla quarta ginnasio nel 1899, esame di licenza ginnasiale nel 1901, prima liceo al Torricelli nel 1901-02.
Nel 1899-00, ultimo anno di ginnasio per Dino, i Campana all'Istituto Salesiano diventano tre. Si è aggiunto, allievo di seconda ginnasio, Manlio, fratello di Dino, di due anni più giovane di lui. Vi rimarrà solo un anno perché quando Dino passerà al Torricelli, Manlio lo seguirà. Quel luglio del 1900, passato alla storia per l’uccisione di Umberto I, è per i fratelli Campana il mese degli esami. Manlio affronta, unico candidato, l'esame di ammissione alla terza ginnasiale; respinto, viene comunque ammesso su domanda alla seconda. Dino si presenta con altri venticinque candidati all'esame per la licenza ginnasiale4.
Dello svolgimento siamo informati fin nei dettagli. Trattandosi di esame conclusivo, con un forte carattere di ufficialità, il cavalier Flaminio del Seppia deve inviare quotidianamente al provveditore la relazione sulle prove svolte. Da venerdì 6 luglio a mercoledì 11 si svolgono i cinque scritti. Si inizia ogni giorno alle sette e mezzo; sei ore per il componimento italiano, cinque per le altre prove. Per ogni prova scritta, vengono preparate tre tracce; la scelta è affidata ad un pubblico sorteggio.
Si parte naturalmente con italiano. Riportiamo le tre tracce, che ci sembrano indicative di un certo clima pedagogico:
1. Le male azioni, non la povertà, disonorano l'uomo
2. Guardando il ritratto del padre morto combattendo per la libertà della patria
3. Alla vigilia degli esami: riflessioni di uno scolaro.
Viene sorteggiata la terza. Secondo una testimonianza del dottor Collina5, assai posteriore ed ignorata dai tanti che si sono posti il problema degli inizi poetici di Campana, Dino svolse il tema in versi e "fu quella una delle ragioni per cui alcuni degli studenti faentini gli si legarono d'amicizia e di stima". La notizia però appare sospetta. Improbabile che Dino, di cui fino ad allora non sono attestati comportamenti originali, abbia voluto dare questa prova di stravaganza alla prima prova d'esame, in un ambiente a lui estraneo. Tanto più con quella traccia, certo la più insipida delle tre6. E poi un tema d'esame è un documento riservato; rimane chiuso in una busta e viene letto da una sola persona. Se Dino l'avesse svolto in versi, come ne sarebbe venuto a conoscenza Giovanni Collina, che forse in quel luglio 1900 nemmeno lo conosceva? E come avrebbe potuto il poeta esordiente ricavarne popolarità fra i compagni? Probabile però che a fondamento della notizia ci sia un episodio posteriore di qualche mese, quando Dino, alunno di prima liceo, frequenta la famiglia Collina7. Sempre che non sia solo una delle tante leggende sorte intorno al futuro ospite di Castel Pulci.
Seguono le due prove di latino. La versione dall'italiano (sabato 7 luglio) proviene dell'antologia scolastica di Carducci. E' un passo dell'undicesimo capitolo del Galateo di monsignor Della Casa8. Quella dal latino (lunedì 9) è presa dall'antologia di Gandino9.
Carducci, Gandino: nelle memorie del Torricelli questi due nomi sono associati per un'ispezione compiuta nel 1887. Mentre però i rapporti col liceo faentino dell'illustre latinista si esauriscono in quella visita e nella conseguente relazione ufficiale, i legami di Carducci, assai più stretti e duraturi, risalgono ai tempi della fondazione del liceo (1860) e sono ancora ben vivi ai tempi di Campana studente, che avrà, come vedremo, professori appartenenti all'entourage carducciano ed a cui non mancò l'occasione di vedere a Faenza il vecchio vate. Palazzo Pasolini, spesso frequentato da Carducci, è a poche decine di metri dal Palazzo degli studi.
La versione dal greco, presa dal manuale di Ernst Koch10, è una compilazione di aneddoti sulle donne spartane, basata su passi di Plutarco. Quella in francese un paragrafo di un raccontino moraleggiante di Augusto Conti inserito in un'antologia scolastica di Ferdinando Martini11.
Fra il 12 ed il 16 si svolgono gli orali, il 17 luglio vengono pubblicati i risultati. Fra i quattordici promossi in prima sessione c'è Dino che sfiora la media del sette con la seguente pagella:
 La 5 ginnasio 1903-04 con Manlio Campana (fratello di Dino), Michele Collina (fratello di Giovanni), Celio Posocco (figlio di Cesare Ugo)
La 5 ginnasio 1903-04 con Manlio Campana (fratello di Dino), Michele Collina (fratello di Giovanni), Celio Posocco (figlio di Cesare Ugo)
|
scritto |
orale |
|
|
Italiano |
7 |
8 |
|
Versione dal latino |
7 |
7 |
|
Versione in latino |
6 |
|
|
Greco |
6 |
6 |
|
Storia |
8 |
|
|
Geografia |
6 |
|
|
Matematica |
6 |
|
|
Storia Naturale |
7 |
|
|
Francese |
912 |
7 |
I commissari che firmano il quadro dei voti sono gli stessi di due anni prima; solo al professor Casali si è sostituito Giuseppe Morini (1842-1923)13, titolare di lettere al ginnasio superiore. E' un docente di vecchia esperienza, autore di svariati manuali scolastici, amico e corrispondente di Giosue Carducci: è lui il personaggio che appare in una serie di foto, a braccetto con il vecchio poeta per le vie del centro o sotto gli archi della piazza «leggieri e potenti» come Dino li descriverà nei Canti Orfici14.
Troviamo quindi i due fratelli Campana al Torricelli nell'anno scolastico successivo: Dino alunno di prima liceo, Manlio di seconda ginnasio. Fra i due ci sono due anni per l'anagrafe, quattro per la scuola: Dino ha guadagnato un anno, Manlio ne ha perso uno. Ma al termine dell'anno, solo Manlio sarà promosso (e procederà negli anni seguenti al Torricelli, fino alla licenza ginnasiale), mentre, come è ben noto, l'anno scolastico di Dino si compirà disastrosamente. Il prospetto dei voti ci permette di ricostruire l'evoluzione di profitto e condotta di Dino nel corso dell'anno scolastico.
|
I bimestre |
II bimestre |
III bimestre |
IV bimestre |
Class.finale |
Esami I sess. |
Esami II sess |
||||||||||||
|
S |
O |
C |
S |
O |
C |
S |
O |
C |
S |
O |
C |
P |
C |
S |
O |
S |
O |
|
|
Italiano |
4 |
7 |
10 |
6 |
7 |
10 |
5 |
6 |
5 |
6 |
7 |
8 |
5 |
7 |
6 |
6 |
||
|
Latino |
7 |
5 |
8 |
6 |
4 |
6 |
5 |
5 |
7 |
3 |
4 |
7 |
4 |
7 |
escluso |
5 - 5 |
- |
|
|
Greco |
7 |
4 |
8 |
5 |
4 |
6 |
4 |
3 |
7 |
2 |
3 |
7 |
4 |
7 |
escluso |
4 |
- |
|
|
Storia |
7 |
10 |
7 |
10 |
6 |
9 |
6 |
9 |
6 |
9 |
3 |
n.p. |
||||||
|
Filosofia |
5 |
10 |
6 |
9 |
6 |
8 |
5 |
8 |
5 |
9 |
6 |
|||||||
|
Matematica |
6 |
10 |
5 |
6 |
5 |
6 |
6 |
7 |
6 |
7 |
4 |
n.p. |
||||||
|
Chimica15 |
6 |
10 |
6 |
10 |
7 |
10 |
6 |
9 |
6 |
8 |
3 |
n.p. |
||||||
|
St. Naturale |
6 |
10 |
7 |
8 |
7 |
9 |
6 |
9 |
6 |
9 |
5 |
n.p. |
||||||
|
Ginnastica |
8 |
10 |
- |
- |
8 |
10 |
8 |
10 |
||||||||||
|
Assenze |
21 |
6 |
2 |
10 |
||||||||||||||
L'anno si compone di quattro bimestri; al termine di ogni bimestre viene assegnato per ogni materia, oltre al voto (o ai voti) di profitto, un voto di condotta. Seguono lo scrutinio finale (sempre con condotta), che non coincide con quello del quarto bimestre e gli esami, tutti con professori interni, di luglio e di ottobre. Gli alunni che nello scrutinio finale riportano almeno otto in profitto ed otto in condotta sono dispensati dagli esami, viceversa sono esclusi dall'esame estivo e rimandati direttamente a quello autunnale «nelle materie nelle quali allo scrutinio finale abbiano ottenuto nel profitto o nella condotta una classificazione inferiore a sei decimi»16. Quindi il voto di condotta segue una scala che non è quella attuale; insomma con sei in condotta si viene promossi e l'unica insufficienza in condotta di questo quadro è quella in italiano nel terzo bimestre.
I voti attestano un calo progressivo di bimestre in bimestre, seguito da un crollo agli esami. In latino e greco, il quattro dello scrutinio finale esclude l'alunno dalla prima sessione dell'esame. A luglio le uniche materie sufficienti risultano italiano e filosofia; ad ottobre il fallimento negli scritti di latino e greco rende inutile il proseguimento e Dino non si presenta agli orali.
 Il preside Flaminio del Seppia nel 1905, al centro di un gruppo di studenti ed insegnanti. L'ultimo a destra della seconda fila dovrebbe essere Antonio Messeri. Le due donne sono probabilmente mogli di insegnanti.
Il preside Flaminio del Seppia nel 1905, al centro di un gruppo di studenti ed insegnanti. L'ultimo a destra della seconda fila dovrebbe essere Antonio Messeri. Le due donne sono probabilmente mogli di insegnanti.
È ancora preside il cavalier Flaminio del Seppia. Sessantacinquenne originario della provincia di Pisa, volontario nella seconda guerra di indipendenza, è stato rettore del celeberrimo collegio Cicognini di Prato dove ha avuto come alunno Gabriele D'Annunzio. Nelle Faville del Maglio, D'Annunzio ritrarrà in forme caricaturali il suo paedagogus paedagogorum rievocando in pagine ricche di invenzioni verbali i contrasti avuti con lui17. Da Prato, Del Seppia è giunto a Faenza una prima volta nel 1882. Ma se ne è allontanato dopo un anno di contrasti con l'ambiente, culminati con una sassaiola organizzata da un gruppo di alunni e con i conseguenti strascichi disciplinari ed anche giudiziari. Tornato dopo un decennio, vi ha trovato un ambiente assai più tranquillo e vi rimarrà fino al pensionamento nel 1907. Testimonianze dell'epoca lo descrivono come un personaggio grave e severo, tutto compreso dell'importanza del ruolo. Una descrizione che appare confermata da una foto del 1905 che lo ritrae, imponente vegliardo con un'ampia barba bianca, circondato da insegnanti ed alunni.
Nel 1900 l'esiguo corpo insegnante del liceo si sta radicalmente rinnovando, almeno per quanto riguarda le materie umanistiche. Sulla cattedra di italiano, che fu di Isidoro del Lungo, di Giuseppe Cesare Abba, di Severino Ferrari, è appena giunto Cesare Ugo Posocco, originario di Vittorio Veneto, autore di studi su Petrarca e Leopardi, di traduzioni poetiche dal francese ed anche di poesie in proprio, pubblicate in volumetti dalla grafica raffinata. All'epoca ha quarantanove anni ed una carriera alle spalle fatta di trasferimenti per i licei della penisola, inframmezzati da lunghe aspettative per malattia. E' stato già al Torricelli qualche anno prima ed ora vi ritorna in seguito ad un evento drammatico: il titolare, lo stimatissimo professor Andrea Dall'Oglio, ha dapprima tentato il suicidio (aprile 1900), poi è stato ricoverato in manicomio a Imola18. Nella corrispondenza fra il cavalier Flaminio ed il provveditore l'evento è messo in relazione con difficoltà economiche ma anche con il «carattere irrequieto della madre», anch'essa in passato ricoverata in manicomio.
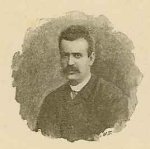
Il professore di italiano Cesare Ugo Posocco. Ritratto in Studio sui fiori, Milano, Aliprandi, 1895, p. 3
Di Posocco, le relazioni del paedagogus paedagogorum riprendono la propensione a stare «fuori dell’istituto con i suoi scolari a discorrere, e magari qualche volta a bere», mentre lodano «la facilità della parola calda ed eloquente» e «la diligenza che pone nella correzione dei lavori»19. Ascriviamo dunque alla soverchia diligenza impiegata da questo melenso versificatore d'occasione nel correggere i compiti in classe la responsabilità di avere stroncato con ripetute insufficienze gli esordi letterari di Dino, anzi gli esordi poetici se la notizia del tema in versi ha un fondamento. Ma, incassato senza protestare il quattro allo scritto del primo bimestre, raggiunta la sufficienza nel secondo in cui Posocco, lungamente assente per malattia, fu sostituito dal collega di storia Antonio Messeri, Dino reagì forse in forme irrispettose alla nuova insufficienza nel terzo. Che ci sia stato uno scontro fra il professor Posocco e l'allievo Campana in quella primavera 1901 è più di una congettura, perché il cinque in condotta non è sanzione di poco conto. Due anni prima Del Seppia era stato ripreso dal provveditore per un cinque in condotta non adeguatamente motivato: «il cinque in condotta è votazione grave e vergognosa, alla quale (…) non si dovrebbe ricorrere che in seguito a fatti precisi e determinati»20. Ma dei fatti precisi che riguardano Campana non rimane alcuna traccia né in ciò che resta delle carte riservate, né nel verbale di quel Collegio dei professori dell'8 maggio 1901 in cui furono assegnati i voti del terzo bimestre21.
Sappiamo invece dai verbali quali sono i libri adottati dal prof. Posocco: Il Sommario di storia della letteratura italiana di Giuseppe Finzi (edizione Loescher), la Commedia nel classico commento di Scartazzini, le Rime di Petrarca nell'edizione Barbera, una scelta di novelle del Decameron a cura di Raffaello Fornaciari.
Altre turbolenze scuotono la vita del Torricelli per quanto riguarda il latino ed il greco. Il professor Tassis, l'anno precedente, è stato contestato apertamente dagli studenti di terza liceale, che in una lettera al preside non si limitavano ad affermare che egli «non fa nulla delle sue materie», ma denunciavano anche un «alteramento delle facoltà mentali» del professore che dava in escandescenze durante le lezioni e nella cui mente «regnava il massimo disordine». La lettera era firmata da tutti gli alunni salvo uno: il figlio del professore stesso. Che nella lettera era accusato anche di nepotismo. Il preside, che nelle note annuali ha sempre espresso giudizi assai poco lusinghieri sul Tassis, ha preso la parte degli studenti ed è stato per questo ripreso dal provveditore. Ne è seguita nella primavera del 1900 una guerra privata fra professore e preside, fatta di volantini anonimi a stampa e scritte notturne sui muri della scuola, di cui Dal Seppia sospetta responsabile il professore22.
Trasferito Tassis al termine del 1899-00, il posto vacante in organico viene coperto ad anno scolastico iniziato da un brillante e severissimo giovane, Eleuterio Menozzi da Correggio, studioso di Catullo ed autore di un manuale di metrica latina. Menozzi informa presto il preside che la situazione è disastrosa: «le classi mancano delle più elementari cognizioni e rivelano una fenomenale ignoranza», specialmente nel greco. Un disastro che si riflette nelle valutazioni bimestrali, in cui fioccano i tre, i due ed anche gli zeri. Veramente il disastro riguarda la seconda e la terza, non tanto la prima, dove sono presenti «ottimi elementi come l'Assirelli». Un nome che dovremo riprendere. Fra questi ottimi elementi non possiamo certo annoverare Campana, che all'orale è sempre insufficiente, mentre allo scritto i suoi voti, discreti nel primo bimestre, decrescono nei successivi fino a precipitare nel quarto.
Aggiungiamo intanto l'elenco dei testi adottati in prima liceo dal terribile Eleuterio: per latino il Compendio di storia della letteratura di Ermanno Bender, le Georgiche, il secondo libro delle Odi di Orazio il quarto e quinto libro di Livio, la Divinatio in Caecilium di Cicerone; per greco la sintassi di Giovanni Zenoni, Brani scelti di prosa greca di Giovanni Battista Bonino, il Compendio storico della letteratura greca di Augusto Romizi, il quinto libro dell'Iliade ed il terzo dei Memorabili di Senofonte23.
 Caricatura di Antonio Messeri, professore di storia di Dino
Campana. Lo studente, Giornale settimanale studentesco, a. I n. 4, Faenza, 22 gennaio 1911, p. 2.
Caricatura di Antonio Messeri, professore di storia di Dino
Campana. Lo studente, Giornale settimanale studentesco, a. I n. 4, Faenza, 22 gennaio 1911, p. 2.
Sulla cattedra di storia, dove fino al 1898 sedeva Gaetano Salvemini, ora c'è Antonio Messeri. E' un fiorentino trentaduenne, giunto al Torricelli da un anno: vi rimarrà fino al 1912 coprendo anche la carica di preside. Del gruppo è tuttora il più noto a Faenza; il suo Faenza nella storia e nell'arte, scritto insieme ad Achille Calzi, viene ancora ristampato, come pure una monografia su re Enzo. È anche autore di manuali scolastici di storia e di grammatica, frequentatore del salotto della contessa Silvia Pasolini e quindi di Giosue Carducci. Le fonti ne ricordano lo spirito salace «infiorato dal suo caustico brio toscano»24 ed anche gli atteggiamenti apertamente anticlericali. Viene dunque accusato di «canzonare pubblicamente in classe i giovani noti per i loro sentimenti religiosi» e di discriminare gli alunni provenienti dai salesiani. Ne nasce un caso in cui interviene anche la stampa locale. Col provveditore, che gliene chiede conto, Del Seppia minimizza incolpando l'eccessivo potere dei clericali faentini. Racconta anche di un incontro col direttore dell'Istituto Salesiano che è venuto da lui per «chiedergli consiglio»: un alunno di prima liceo è tornato «confuso e mortificato» dopo la prima lezione di Messeri e ora non vuole più tornare a scuola. Teme che altri lo seguano e sarebbe un gran dispiacere per i salesiani che hanno sempre mandato tanti alunni al Torricelli. Più che la richiesta di un consiglio, sembra una minaccia: che però non avrà seguito25. Del resto, se si osservano i voti, l'ex collegiale Dino Campana non sembra discriminato dal professore mangiapreti: la storia è anzi delle materie umanistiche l'unica in cui egli non scende mai sotto la sufficienza, almeno fino agli esami.
Messeri è anche bibliotecario e segretario del Collegio dei professori; adotta come libro di testo la Breve storia del Medio Evo di Francesco Comani.
Il professore di filosofia è da un anno Francesco Paolo Pugliese, trentaseienne di Ortanova (Foggia); secondo il preside ha «ingegno penetrante e colto» e «sa fare intendere bene la materia che insegna, tenendo sempre desta negli alunni l’attenzione e ferma, ove occorre, la disciplina»26. Almeno quando c'è, perché nel corso dell'anno risulta assai spesso assente. Manuale adottato il Corso elementare di Filosofia di Carlo Cantoni.
L'insegnamento delle materie scientifiche è affidato a tre quarantenni stabilmente trapiantati a Faenza: Cristiano Rodighiero di Asiago (matematica), Enrico Mori di Pavia (chimica), che funge anche da vice preside, e Giovanni Gottardi di Vervò, provincia di Trento (storia naturale, cioè scienze). Secondo Del Seppia sono tutti insegnanti coscienziosi e preparati; Mori e Gottardi si fanno anche ben volere dagli alunni. Rodighiero forse un po' meno, se è vero che per imporre la disciplina giunge talvolta a schiaffeggiare gli alunni, come lamenta in una lettera la mamma di un alunno del ginnasio e confermano altre segnalazioni di altri anni scolastici. Nulla comunque che riguardi la classe di Dino.
Sembrerebbe dalle valutazioni bimestrali che Campana riesca meglio nelle materie scientifiche che in quelle umanistiche; la realtà è che almeno chimica e scienze non rappresentano uno scoglio per nessuno. Anche in queste materie i voti di Campana sono allineati con quelli dei peggiori della classe. L'unica materia in cui Dino eccelle è la ginnastica. La valutazioni assegnategli dal maestro Alfredo Chiarini sono le migliori della classe, a pari merito con quelle di altri due alunni, in ciascun bimestre salvo che nel secondo in cui non si tennero le lezioni, presumibilmente per il maltempo.
Le lezioni iniziano il 16 ottobre e terminano il 22 giugno; seguono dal 1 al 16 luglio gli esami. La classe di Dino è composta da ventiquattro alunni: Aldo Albonetti, Silvio Alvisi, Carlo Andalò, Oddone Assirelli, Michele Baldrati, Gustavo Benini, Augusto Biffi, Dino Campana, Ugo Capetti, Ezio Casati, Tullo Cenni, Luigi Dalprato, Federico Frontali, Aldo Gallamini, Fortunato Carlo Landi, Giovanni Morsiani, Giuseppe Neri, Francesco Savelli, Giacomo Tacconi, Aderito Tosi, Armando Tosi, Gaddo Vincenzoni, Giuseppe Zanotti, Giovanni Zauli27. Tre sono ripetenti, nove provengono dal ginnasio Torricelli, sei da quello di Imola, tre da quello di Lugo, tre dai salesiani. Nessuna Francesca B.28, anzi nessuna ragazza. In tutto il Liceo Ginnasio (128 alunni) la componente femminile è limitata a due bambine di prima ginnasio.
Nessuno fa il pendolare. Con le lezioni che spesso si protraggono nel pomeriggio29, tutti, anche gli imolesi, hanno trovato un domicilio a Faenza30. I fratelli Campana risultano residenti «presso la famiglia» a pochi metri dall'Istituto Salesiano in via Bondiolo al numero 528 della numerazione napoleonica, corrispondente all'attuale numero 16. Lì c'è un appartamento che Francesca «Fanny» Luti ha preso in affitto per accudire i figli studenti31. Poco più in là, al numero 584 (ora 28) abita la famiglia Collina.
Chi sfoglia i carteggi di quell'anno scolastico, abbrunati per la morte di re Umberto, alla ricerca del nome di Dino Campana, rimane deluso. Quando, ad esempio, il Torricelli partecipa ad una colletta nazionale per offrire una medaglia d'oro al duca d'Abruzzo per la sua impresa al Polo, tutti i professori aderiscono, molti studenti si adeguano, anche il nome di Manlio appare nell'elenco dei sottoscrittori: quello di Dino no32. Di quei ventiquattro nomi, uno solo ricorre nelle relazioni dei professori: è Oddone Assirelli, un alunno che tutti additano come modello. C'è qualcosa di eccessivo nelle pagelle di questo ragazzo: due nove e tutti dieci in prima, un solo nove e tutti dieci in seconda, tutti dieci senza eccezioni in terza. Forse è il curriculum più brillante di tutta la storia del Torricelli. Anche nel registro dei prestiti della biblioteca scolastica il suo è di gran lunga il nome che ricorre più spesso, mentre quello di Dino Campana non vi appare mai. Ma Oddone Assirelli è un alunno esemplare anche sotto altri aspetti, almeno dal punto di vista dell'autorità scolastica. Quando, l'anno successivo, il professor Menozzi sarà accusato di avere offeso gli alunni, Assirelli invierà al «veneratissimo signor Preside» una lettera per precisare che non di oltraggi si trattava, ma delle manifestazioni di «uno sdegno nobile e sacro»33. Quando, due anni più tardi, i liceali scenderanno in sciopero contro le nuove disposizioni ministeriali sugli esami, «l'esemplarissimo giovanotto Assirelli»34 sarà l'unico a presentarsi puntualmente alle lezioni.
 Classe 1A Ginnasio 1934-35. E' una delle tante foto di classe con il prof. Oddone Assirelli, "antico compagno di scuola" di Dino Campana.
Di lui i non pochi alunni superstiti ricordano tre cose: la bontà, la sordità e la singolare somiglianza con Charlie Chaplin.
Classe 1A Ginnasio 1934-35. E' una delle tante foto di classe con il prof. Oddone Assirelli, "antico compagno di scuola" di Dino Campana.
Di lui i non pochi alunni superstiti ricordano tre cose: la bontà, la sordità e la singolare somiglianza con Charlie Chaplin.
Proprietà del prof. Francesco Emiliani.
Oddone Assirelli (Dovadola 1883 - Faenza 1960) dopo la laurea tornerà al Torricelli dove insegnerà lettere al ginnasio dal 1919 al 1940, poi terminerà la carriera come docente universitario a Bologna. Allievo del grande linguista Alfredo Trombetti, scriverà un ponderoso trattato sulle lingue africane, che sarà edito da Zanichelli e poi anche tradotto in francese. Ma se ci soffermiamo su di lui il motivo è un altro: di lui Dino Campana si ricorderà nei Canti Orfici. È certamente lui «l'antico compagno di scuola», che ne La giornata di un nevrastenico si ferma a parlare con Dino per le vie di Bologna e gli suggerisce «con un sorriso sempre più lercio»35 di mandare i suoi testi poetici ad un settimanale mondano, suscitando nel poeta il rigurgito di un'antica antipatia. Si veda la testimonianza resa a Pariani: «era uno di Dovadola, professore di belle lettere»36.
Il collegio dei professori che si riunisce il 12 ottobre 1901, più che sanzionare la bocciatura di Dino Campana, prende atto della sua rinuncia a proseguire. Da allora in poi il cammino di Dino prenderà altre strade.
Che cosa resta in Campana dell'esperienza al Torricelli? I biografi individuano in quell'anno uno snodo decisivo della sua vicenda, in questo sostenuti sia dalle testimonianze dei familiari sia da quelle del poeta stesso, che collocano intorno ai quindici anni i primi gravi disturbi nervosi. Quale ruolo abbiano avuto nell'intreccio delle motivazioni gli insuccessi scolastici, le «distrazioni» di cui enigmaticamente parla Pariani37, i turbamenti adolescenziali, le patologie ereditarie, i conflitti insorti in quel gruppo familiare ristretto costituitosi in via Bondiolo lontano dal padre e dal suo probabile ruolo moderatore, è questione aperta. Tutt'al più possiamo, come s'è visto, mostrare l'infondatezza di qualcuna delle ipotesi che sono state avanzate: l'innamoramento per una compagna, i disagi del pendolarismo.
 Lo scalone del liceo (e della pinacoteca) come si presentava ai tempi di Dino Campana. Spiccano il busto di Vittorio Emanuele II che sarebbe stato poi sostituito da quello di Evangelista Torricelli, i medaglioni laterali con le armi di Casa Savoia, a cui sarebbe subentrata la riproduzione di un diploma settecentesco del Ginnasio Comunale.
Lo scalone del liceo (e della pinacoteca) come si presentava ai tempi di Dino Campana. Spiccano il busto di Vittorio Emanuele II che sarebbe stato poi sostituito da quello di Evangelista Torricelli, i medaglioni laterali con le armi di Casa Savoia, a cui sarebbe subentrata la riproduzione di un diploma settecentesco del Ginnasio Comunale.
Ma è possibile rintracciare anche nell'opera di Campana segni che rimandano direttamente al suo passato di liceale a Faenza. Intanto, è un caso ben singolare che dei non pochi personaggi che appaiono nei Canti Orfici l'unico finora identificabile, dopo Regolo Orlandelli, sia un compagno di scuola. Poi, ci sono echi di letture fatte in classe; ad esempio, la vistosa citazione petrarchesca con cui si apre la Poesia facile del Quaderno38 ha tutta l'aria di una reminiscenza scolastica ed uno spoglio un po' più accurato darebbe certamente risultati più copiosi. Infine, c'è la celebre pagina sul museo di Faenza39: solo il lettore faentino dei Canti Orfici sa che l'«antico palazzo rosso» della pinacoteca è lo stesso Palazzo degli studi che fu teatro delle sue disavventure di studente, che per raggiungere le sale di esposizione occorreva passare davanti alle aule scolastiche e davanti all'ufficio del paedagogus paedagogorum. Al tempo della visita descritta nei Canti Orfici, da quelle disavventure è trascorsa almeno una decina di anni, nell'ufficio che è stato del cavalier Flaminio forse ora siede Antonio Messeri, le figure femminili che «passano a scatti» potrebbero ora essere di ginnasiali e di liceali nei corridoi40. Ma in quella definizione di antico palazzo rosso, se il secondo dei due aggettivi rimanda alla tonalità tipica che Faenza assume nei Canti, il primo, più che rimarcare i secoli di vita dell'ex collegio dei gesuiti, sembra evocare ricordi personali41, evidenziare una consuetudine ed un'appartenenza.

